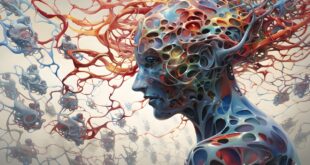C’è un termine giapponese che racchiude un concetto tanto semplice quanto profondo: skinship. È una parola che nasce dall’unione di “skin”, pelle, e “relationship”, relazione, e descrive l’intimità costruita attraverso il contatto fisico.
Non è limitata alla sfera sessuale, ma abbraccia anche i gesti di affetto quotidiano, le carezze tra genitori e figli, gli abbracci tra amici, i piccoli momenti di vicinanza che definiscono il senso di appartenenza. Nel linguaggio giapponese, skinship esprime la consapevolezza che la pelle è un linguaggio, che toccare e lasciarsi toccare è un modo per dire “ci sono”, “sei al sicuro”, “ti vedo”.
La psicologia occidentale è arrivata più tardi a riconoscere la stessa verità. Gli studi sulle relazioni umane mostrano che il contatto affettuoso, quando percepito come sicuro e accogliente, migliora la salute mentale, riduce l’ansia, regola i livelli di cortisolo e rafforza i legami affettivi. Il tatto, in altre parole, è una forma primaria di comunicazione emotiva. Ma allora perché alcune persone non riescono a sopportarlo, nemmeno da parte di chi amano?
Perché odio il contatto fisico? Il legame tra attaccamento e contatto
Per rispondere, è utile partire dalle teorie sull’attaccamento, che descrivono come ciascuno di noi costruisce il proprio modo di legarsi agli altri. Durante l’infanzia, il rapporto con la figura di accudimento, spesso la madre o il padre, definisce le fondamenta emotive sulle quali si svilupperanno le relazioni adulte. Quando un bambino cresce con la certezza che i suoi bisogni emotivi saranno accolti, tende a sviluppare uno stile di attaccamento sicuro: si fida, ricerca la vicinanza, ma non la teme.
Quando invece l’ambiente non risponde in modo coerente o affettuoso, il sistema si adatta. Alcuni bambini imparano a diventare iper-vigilanti, a reclamare attenzioni con insistenza, sviluppando uno stile di attaccamento ansioso. Altri, invece, traggono una conclusione opposta: “Non posso contare sugli altri, quindi non ho bisogno di nessuno.” Nasce così lo stile di attaccamento evitante.
Da adulti, queste persone possono apparire autonome, indipendenti, perfino fredde. In realtà, hanno imparato a proteggersi dal rischio del rifiuto tenendo gli altri a distanza. Il contatto fisico, che per molti è un linguaggio di amore, per loro può rappresentare un’invasione. Un gesto come una carezza o un abbraccio può evocare sensazioni spiacevoli: imbarazzo, tensione, talvolta persino paura.
Quando la vicinanza genera disagio
Uno studio condotto dalla psicologa Anik Debrot all’Università di Losanna ha esplorato proprio questo paradosso: se il contatto fisico favorisce il benessere, perché alcune persone ne traggono disagio? E soprattutto, le persone che tendono a evitarlo potrebbero, con il tempo, imparare a trarne beneficio?
Il primo passo della ricerca è stato un ampio sondaggio su oltre 1.600 individui coinvolti in relazioni sentimentali. È emerso che chi mostra un contatto fisico più frequente con il partner tende a riportare livelli più elevati di benessere emotivo. Le persone con attaccamento evitante, invece, riferiscono meno gesti affettuosi e un benessere psicologico inferiore. Tuttavia, tra loro c’erano eccezioni: individui che, pur con un profilo evitante, mantenevano una buona abitudine al contatto, e questi mostravano livelli di benessere simili a chi possedeva uno stile sicuro.
In altre parole, il contatto non li danneggiava, anzi, li aiutava. Il problema, dunque, non è tanto la mancanza di beneficio, quanto la difficoltà a lasciarsi andare. È come se il corpo avesse imparato a temere ciò che, in realtà, potrebbe curarlo.
Leggi anche:
Il tocco che costruisce fiducia
In una seconda fase, Debrot e il suo team hanno invitato alcune coppie a partecipare a conversazioni intime in laboratorio, analizzando la frequenza dei gesti affettuosi e i cambiamenti dell’umore. Anche in situazioni delicate, il contatto non ha generato disagio né effetti negativi, nemmeno tra i partecipanti più distaccati. Tuttavia, non era il singolo gesto a produrre benessere immediato, quanto la qualità costante della relazione: il modo in cui il contatto viene vissuto, giorno dopo giorno, come segno di fiducia e sicurezza.
Il terzo studio, durato 28 giorni, ha aggiunto un altro tassello. Quando un partner con stile evitante si mostrava più aperto alle manifestazioni tattili dell’altro, il beneficio non era solo suo, ma si estendeva anche al partner, migliorando l’umore di entrambi. È una conferma di quanto il corpo, attraverso la pelle, comunichi reciprocità e conforto, anche dove le parole falliscono.
Le radici del rifiuto del contatto
Chi rifugge il contatto fisico non lo fa per scelta razionale. È una risposta che si forma lentamente, spesso in modo inconsapevole. Può derivare da esperienze infantili in cui il tocco era assente, incoerente o associato a disagio. Altre volte, da modelli familiari dove l’affetto era espresso solo verbalmente o attraverso gesti di cura pratici, ma privi di tenerezza. In alcuni casi, il rifiuto nasce da esperienze di invasione, da traumi legati alla perdita di controllo o alla paura di essere vulnerabili.
Il corpo, in questi contesti, diventa un confine da difendere. Ogni tocco è interpretato come una minaccia, non come un segnale d’amore. Questo schema, se non riconosciuto, può accompagnare la persona per decenni, alimentando una sensazione di solitudine che non si risolve nemmeno nelle relazioni più affettuose, perché la distanza non è più fisica, ma interiore.
Leggi anche: Afefobia: cos’è e quali le principali cause della paura del contatto fisico
Ri-educare il corpo alla fiducia
La psicologia contemporanea non considera questi schemi come irreversibili. Gli stili di attaccamento possono modificarsi nel tempo, specialmente se si sviluppa una consapevolezza di sé più profonda. Le terapie basate sulle emozioni e sull’attaccamento lavorano proprio su questo: aiutare la persona a riconoscere le proprie paure legate all’intimità, imparando a tollerare gradualmente la vicinanza fisica e affettiva.
Il processo è delicato, perché il tocco non può essere imposto. Deve essere riscoperto come linguaggio di fiducia, passo dopo passo. Anche piccoli gesti, come prendersi la mano o abbracciarsi per qualche secondo in più, diventano parte di una rieducazione sensoriale. Non si tratta di forzare la spontaneità, ma di permettere al corpo di riassociare il contatto a sensazioni di sicurezza, e non di allarme.
La skinship dei giapponesi ci ricorda che il legame passa anche dalla pelle, e che la distanza non è sempre sinonimo di libertà. A volte è solo il segno di una ferita antica che può essere curata con la stessa materia di cui è fatta la ferita stessa: il contatto umano. Un abbraccio che non spiega, ma comprende, una carezza che non pretende, ma resta.
 Psico.it Psicologia, Psicoterapia e Benessere
Psico.it Psicologia, Psicoterapia e Benessere