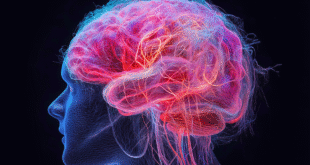Non è raro che una persona affetta da cleptomania arrivi a chiedere aiuto dopo anni di silenzio, quando l’angoscia ha preso il sopravvento e la paura di essere scoperti ha compromesso relazioni, lavoro, equilibrio interiore.
Nella maggior parte dei casi chi soffre di cleptomania tende a rubare cose inutile, di cui non ha bisogno, del quale non si ha desiderio, e quando lo si fa poco dopo non ci si sente soddisfatte, ma il gesto viene seguito da un forte disagio e senso di vergogna.
Vediamo nel dettaglio cosa significa cleptomania in psicologia e in che modo riconoscere il disturbo e qual è il percorso consigliato a chi vuole guarire.
Da dove deriva il termine cleptomania in psicologia e quanto è entrato nel manuale diagnostico
Nel corso dell’Ottocento il termine kleptomanie veniva usato da alcuni psichiatri europei per descrivere una forma di furto compulsivo apparentemente scollegato da ogni motivazione razionale.
Si trattava di un fenomeno che colpiva in prevalenza le donne e che veniva spiegato con ipotesi legate al funzionamento dell’utero o alla sindrome premestruale.
Solo molto più tardi la cleptomania in psicologia ha iniziato a essere trattata come un disturbo del controllo degli impulsi, separato dalla sfera puramente organica. Nel DSM-5, il manuale diagnostico di riferimento in ambito psichiatrico, la cleptomania è classificata tra i disturbi del comportamento dirompente, del controllo degli impulsi e della condotta.
Una collocazione che ne sottolinea la natura patologica, distinguendola nettamente dai furti motivati da necessità, vendetta o interesse economico.
Come si manifesta il disturbo?
Quando si manifesta psicologicamente l’impulso di rubare, anche cose di cui non si ha bisogno, questo non si ferma unicamente ad un episodio. Devono esserci diversi episodi che vanno poi a caratterizzare il quadro clinico psicologico.
Infatti, inizialmente l’impulso arriva improvvisamente, dopo di ché cresce, si fa insistente, finché diventa impossibile da contenere. Il soggetto ruba per riuscire a trovare sollievo, solo che non c’è una gratificazione legata all’oggetto rubato. Nella maggior parte dei casi gli oggetti rubati, infatti, spesso non vengono nemmeno utilizzati. Talvolta vengono nascosti, regalati o buttati via.
Subito dopo, l’effetto del gesto però se si prova inizialmente un po’ di sollievo poco dopo si ribalta e porta ad avvertire sensazioni come: senso di colpa, paura, umiliazione. In alcuni casi, si aggiunge anche il timore concreto di conseguenze penali. Eppure, l’episodio tende a ripetersi, con modalità simili, seppure in momenti diversi.
La cleptomania è un disturbo clinico, con un impatto rilevante sulla qualità della vita, ma per poter parlare di cleptomania in psicologia e in senso clinico, devono essere soddisfatti alcuni criteri precisi. Tra questi:
- il furto deve essere ripetuto nel tempo e non giustificato da un bisogno reale o da un guadagno economico;
- la persona sperimenta una crescente tensione prima del gesto, seguita da una sensazione di sollievo;
- il comportamento non è spiegabile da altri disturbi (come episodi maniacali o disturbi di personalità antisociale).
Questo tipo di comportamento viene spesso scambiato per una forma di devianza, anche da professionisti. Ecco perché molti pazienti faticano a parlarne: non temono solo il giudizio della società, ma anche quello del medico o del terapeuta. Alcuni arrivano in terapia per depressione o ansia, omettendo del tutto il sintomo principale.
Cosa succede sul piano neurobiologico
Le evidenze scientifiche non sono ancora esaustive, ma alcuni studi suggeriscono una disfunzione nei circuiti cerebrali legati all’inibizione e alla regolazione degli impulsi.
In particolare, sono stati osservati alterati livelli di serotonina e dopamina, neurotrasmettitori coinvolti nella modulazione del piacere e del comportamento impulsivo. Anche alcune anomalie nelle regioni prefrontali sembrano compromettere la capacità di prevedere le conseguenze delle proprie azioni.
Questa base biologica fornisce un punto di partenza per pensare sia a trattamenti mirati, sia psicologici sia farmacologici.
Spesso la cleptomania non è l’unica patologia
La cleptomania, nella maggior parte dei casi, è associata ad altri disturbi come: depressione maggiore, disturbi d’ansia, disturbi ossessivo-compulsivi, dipendenze da sostanze.
Questo tende a complicare il quadro diagnostico e richiede un approccio terapeutico integrato. In alcuni casi, i sintomi depressivi sono conseguenti al disagio provocato dalla cleptomania stessa. In altri, il furto diventa un modo disfunzionale per regolare emozioni ingestibili.
Non mancano poi i casi in cui la persona riferisce di essere ricorsa al furto in concomitanza con periodi di forte stress, lutti, cambiamenti radicali. Eventi che, pur non essendo la causa unica, possono fungere da catalizzatori.
L’importanza della terapia personalizzata
La psicoterapia, soprattutto quella cognitivo-comportamentale, ha mostrato buoni risultati in chi soffre di cleptomania. In particolare, le tecniche che aiutano il paziente a riconoscere l’impulso prima che diventi ingestibile, e a sostituire il comportamento con strategie alternative di regolazione emotiva.
In presenza di comorbilità, può essere utile introdurre una terapia farmacologica, ad esempio con inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina (SSRI) o stabilizzatori dell’umore. In casi selezionati, sono stati impiegati anche farmaci utilizzati per trattare le dipendenze.
Ciò che conta, in ogni caso, è la costruzione di una relazione terapeutica fondata sulla fiducia. Un contesto in cui il paziente non si senta giudicato, ma accolto e compreso.
Il rischio maggiore della cleptomania è il suo silenzio. La persona sa che il comportamento è socialmente inaccettabile, sa che può essere punito, sa che provoca disagio anche in chi lo subisce. Questo alimenta un circuito di evitamento: si tace, si nega, si minimizza, e così si rimane soli ad affrontarlo.
Molti individui affetti da cleptomania faticano a riconoscere il proprio diritto alla cura. Spesso hanno vissuto episodi di umiliazione o giudizio, talvolta persino in ambito sanitario. Per questo, chi opera nella salute mentale ha il compito di coltivare uno sguardo clinico capace di andare oltre il comportamento e di vedere la persona nella sua complessità, non solo nel sintomo.
 Psico.it Psicologia, Psicoterapia e Benessere
Psico.it Psicologia, Psicoterapia e Benessere