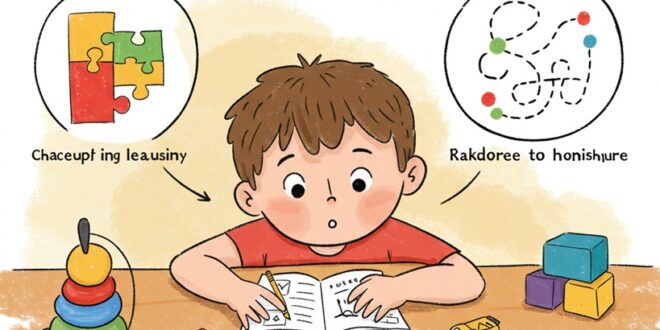L’apprendimento è un processo affascinante che si manifesta in forme diverse e talvolta sorprendenti. Non sempre seguiamo un percorso lineare di stimolo-risposta-ricompensa quando acquisiamo nuove conoscenze. A volte, la nostra mente lavora silenziosamente, raccogliendo informazioni che rimangono dormienti fino al momento in cui diventano utili. Questo fenomeno, noto come apprendimento latente, rappresenta uno degli aspetti più intriganti della psicologia cognitiva e dell’apprendimento.
Le origini dell’apprendimento latente: gli studi di Tolman
Il concetto di apprendimento latente deve molto al lavoro pioneristico di Edward Chace Tolman, psicologo americano che negli anni ’30 del Novecento sfidò le teorie comportamentiste dominanti. In un periodo in cui il paradigma comportamentista di Watson e Skinner sosteneva che l’apprendimento avvenisse esclusivamente attraverso associazioni stimulus-risposta rinforzate, Tolman propose una visione radicalmente diversa.
Nel suo celebre esperimento del 1930, Tolman utilizzò tre gruppi di ratti in un labirinto. Il primo gruppo riceveva un rinforzo (cibo) ogni volta che completava con successo il percorso. Il secondo gruppo non riceveva alcun rinforzo. Il terzo gruppo non riceveva rinforzo per i primi dieci giorni, ma dall’undicesimo giorno in poi veniva premiato con il cibo. I risultati furono illuminanti: il terzo gruppo, una volta introdotto il rinforzo, mostrò un miglioramento drastico delle prestazioni, raggiungendo rapidamente i livelli del primo gruppo. Questo dimostrava che, anche senza rinforzo, i ratti avevano appreso la struttura del labirinto – un apprendimento che era rimasto “latente” fino a quando non era diventato funzionale.
Questo studio rivoluzionario suggeriva che l’apprendimento potesse avvenire in assenza di rinforzo esplicito, contraddicendo l’idea comportamentista che l’apprendimento richiedesse necessariamente un premio o una punizione immediati.
Leggi anche: DSA cosa sono e come riconoscere i disturbi specifici dell’apprendimento
Meccanismi cognitivi dell’apprendimento latente
L’apprendimento latente si basa su meccanismi cognitivi complessi che vanno oltre il semplice condizionamento. Quando esploriamo un ambiente senza uno scopo specifico, la nostra mente crea naturalmente quello che Tolman chiamò “mappe cognitive” – rappresentazioni mentali dell’ambiente che ci circonda e delle relazioni tra i suoi elementi.
Queste mappe cognitive rappresentano una forma di conoscenza strutturale che rimane inattiva fino a quando non diventa rilevante per un obiettivo specifico. È come se la mente umana fosse programmata per assorbire continuamente informazioni dall’ambiente, indipendentemente dalla loro utilità immediata, creando un vasto archivio di conoscenze potenziali a cui attingere quando necessario.
La neuroscienza moderna ha fornito ulteriori prove di questo fenomeno, mostrando come il cervello continui a elaborare e consolidare le informazioni anche in assenza di un’intenzione consapevole di apprendere. Le strutture cerebrali come l’ippocampo svolgono un ruolo cruciale in questo processo, facilitando la formazione di memorie spaziali e contestuali che possono rimanere dormienti fino a quando non vengono attivate da stimoli rilevanti.
L’apprendimento latente nella vita quotidiana
Il concetto di apprendimento latente non è confinato ai laboratori di psicologia, ma si manifesta costantemente nella nostra vita quotidiana. Pensiamo a quando ci trasferiamo in una nuova città: anche senza un’intenzione esplicita di memorizzare il percorso, dopo alcune settimane saremo in grado di navigare attraverso le strade con relativa facilità. Durante le nostre esplorazioni casuali, la mente ha silenziosamente mappato l’ambiente urbano, creando una rappresentazione che diventa attiva quando abbiamo bisogno di raggiungere una destinazione specifica.
Un altro esempio comune si verifica nell’apprendimento linguistico. I bambini assorbono continuamente parole e strutture grammaticali dal loro ambiente, anche senza un insegnamento formale. Questa conoscenza linguistica rimane latente fino a quando non viene attivata dalla necessità di comunicare. Improvvisamente, il bambino utilizza parole o frasi che non ha mai prodotto prima, attingendo al suo archivio di apprendimento latente.
Anche gli adulti sperimentano questo fenomeno quando, ad esempio, ricordano improvvisamente il nome di un attore visto in un film settimane prima, o quando riconoscono un luogo visitato molti anni prima senza averlo consciamente memorizzato. In ciascuno di questi casi, l’informazione era stata acquisita senza un’intenzione esplicita e aveva risieduto nella mente in uno stato latente fino al momento opportuno.
Leggi anche: Ecco come l’apprendimento della lettura “cambia” il cervello
Implicazioni per l’educazione e la psicoterapia
La comprensione dell’apprendimento latente ha profonde implicazioni per i settori dell’educazione e della psicoterapia. Nel contesto educativo, suggerisce che l’apprendimento possa avvenire anche in assenza di rinforzi immediati o valutazioni formali. Gli educatori possono sfruttare questo principio creando ambienti ricchi di stimoli che favoriscano l’esplorazione e la scoperta autonoma, permettendo agli studenti di costruire mappe cognitive che potranno attivare in seguito quando diventeranno rilevanti per obiettivi specifici.
In psicoterapia, il concetto di apprendimento latente aiuta a spiegare come certe esperienze possano influenzare il comportamento senza essere consciamente ricordate. Le terapie basate sull’esposizione, ad esempio, si basano in parte sull’idea che nuove associazioni possano essere apprese e rimanere latenti fino a quando non vengono attivate in situazioni future simili. Questo può essere particolarmente rilevante per il trattamento di fobie e disturbi d’ansia, dove l’obiettivo è spesso quello di creare nuove associazioni che possano sostituire quelle disfunzionali.
Apprendimento latente e memoria implicita
L’apprendimento latente è strettamente correlato al concetto di memoria implicita – quella forma di memoria che influenza il comportamento senza richiedere un richiamo conscio. Quando impariamo a suonare uno strumento musicale, ad esempio, inizialmente dobbiamo concentrarci consciamente su ogni movimento. Con la pratica, questi movimenti diventano automatici, e possiamo eseguire brani complessi senza pensare consapevolmente a dove posizionare le dita.
Questa automatizzazione rappresenta una forma di apprendimento latente: la conoscenza procedurale viene acquisita e immagazzinata in modo tale da poter essere attivata quando necessario, senza richiedere un recupero conscio. I neurologi hanno identificato strutture cerebrali distinte coinvolte in questa forma di apprendimento, in particolare i gangli della base, che sono cruciali per l’acquisizione e l’esecuzione di abilità motorie automatizzate.
La relazione tra apprendimento latente e memoria implicita sottolinea come gran parte del nostro apprendimento avvenga sotto la soglia della consapevolezza, influenzando il nostro comportamento in modi che spesso non riconosciamo consciamente.
Apprendimento latente nell’era digitale
Nell’era digitale, l’apprendimento latente assume nuove dimensioni. La continua esposizione a informazioni attraverso social media, notiziari e altre fonti digitali crea un vasto serbatoio di conoscenze potenziali che possono rimanere dormienti fino a quando non diventano rilevanti. Questo può essere sia un vantaggio che una sfida: da un lato, abbiamo accesso a una quantità senza precedenti di informazioni che possono arricchire le nostre mappe cognitive; dall’altro, la qualità e l’accuratezza di queste informazioni non sono sempre garantite.
Inoltre, l’uso di algoritmi di raccomandazione nei social media e nelle piattaforme di streaming può influenzare inconsapevolmente il nostro apprendimento latente, esponendoci selettivamente a certi tipi di informazioni e limitando la nostra esposizione ad altre. Questa “bolla di filtri” può plasmare le nostre mappe cognitive in modi di cui potremmo non essere consapevoli, influenzando potenzialmente le nostre future percezioni e decisioni.
 Psico.it Psicologia, Psicoterapia e Benessere
Psico.it Psicologia, Psicoterapia e Benessere