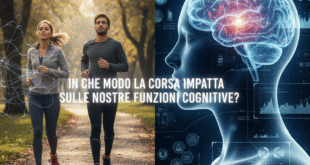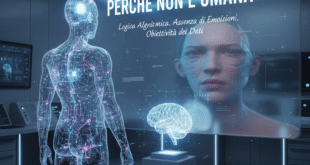Pensa all’ultima volta che hai annusato un profumo familiare o hai sentito una canzone che ti ha riportato indietro nel tempo. Quel primo istante, quella frazione di secondo in cui il tuo cervello cattura l’informazione prima ancora che tu ne sia pienamente consapevole, è merito della memoria sensoriale.
È il primo gradino della nostra capacità di ricordare, quello che spesso diamo per scontato ma che in realtà è fondamentale. Senza questo sistema, non riusciremmo nemmeno a seguire una conversazione o a riconoscere un volto.
Cos’è la memoria sensoriale
La memoria sensoriale è quella capacità del nostro cervello di trattenere per un attimo brevissimo le impressioni che arrivano dai nostri sensi, anche dopo che lo stimolo è sparito. È come se il cervello facesse uno screenshot ultra-rapido della realtà.
Parliamo di un sistema che ha una capienza enorme – può catturare praticamente tutto quello che vediamo o sentiamo in un dato momento – ma che dura pochissimo. Stiamo parlando di frazioni di secondo, al massimo qualche secondo a seconda del senso coinvolto.
Quello che rende interessante la memoria sensoriale è che funziona in modo completamente automatico. Non devi “decidere” di usarla, semplicemente accade. È un processo pre-attentivo, che sta sotto la superficie della nostra consapevolezza. Ne vediamo i risultati solo quando qualcosa cattura la nostra attenzione e passa alla fase successiva di elaborazione.
Ogni nostro senso ha il suo personale “archivio” temporaneo con caratteristiche proprie. I più conosciuti e studiati sono quelli della vista e dell’udito, ma ce ne sono anche per il tatto, l’olfatto e il gusto.
Memoria sensoriale iconica: come funziona la vista
Quando parliamo di memoria sensoriale iconica, ci riferiamo a quella visiva. Il termine lo dobbiamo allo psicologo George Sperling, che negli anni ’60 ha fatto degli esperimenti illuminanti.
Sperling mostrava ai partecipanti una griglia di lettere per un attimo – circa 50 millisecondi, un battito di ciglia – e poi chiedeva loro di ricordarle. La gente riusciva a riportarne solo 3 o 4. Ma qui viene il bello: se invece di chiedere tutte le lettere, un suono indicava quale riga ricordare subito dopo la scomparsa dell’immagine, le persone ne ricordavano molte di più.
Questo ha dimostrato una cosa fondamentale: per una frazione di secondo dopo aver visto qualcosa, l’immagine completa resta “stampata” nella nostra mente. Il problema è che decade rapidamente – parliamo di 250-500 millisecondi al massimo.
Durante questa finestra temporale ultra-breve, l’informazione visiva rimane disponibile con tutti i suoi dettagli sensoriali. Ma se non ci prestiamo attenzione subito, svanisce per sempre.
Le ricerche moderne hanno fatto passi avanti, collegando questi fenomeni alle aree del cervello coinvolte, in particolare la corteccia visiva. Ora sappiamo molto di più su dove e come avviene questo processo nel nostro cervello.
Memoria sensoriale ecoica: l’archivio dei suoni
La memoria ecoica è la versione uditiva di quella iconica. Il nome, coniato da Ulric Neisser, richiama proprio l’idea di “eco” – qualcosa che risuona ancora dopo che il suono originale è finito.
Una differenza importante rispetto alla memoria visiva è che quella uditiva dura di più: tra i 2 e i 4 secondi, contro i pochi decimi di secondo della vista. Perché questa differenza? Probabilmente perché i suoni si sviluppano nel tempo – per capire una parola o una melodia, devi tenere insieme suoni che arrivano uno dopo l’altro.
Prova a pensare a quando qualcuno ti parla: la memoria ecoica ti permette di tenere insieme le sillabe di una parola o le parole di una frase. Senza questo “cuscinetto” temporale, la comprensione del linguaggio sarebbe praticamente impossibile. Dovremmo ricordare attivamente ogni singolo suono, saturando subito la nostra capacità di memoria a breve termine.
Anche per la memoria ecoica gli scienziati hanno usato esperimenti simili a quelli di Sperling, adattati ai suoni. E anche qui i risultati confermano la presenza di questo archivio sensoriale ad alta capacità ma breve durata.
Le neuroscienze hanno individuato nella corteccia uditiva e nelle zone temporali del cervello i centri di questo processo, con pattern di attivazione che persistono anche dopo che il suono è cessato.
Quanto dura la memoria sensoriale per gli altri sensi
Non ci sono solo vista e udito. Anche gli altri sensi hanno i loro registri temporanei, anche se sono stati studiati meno approfonditamente.
La memoria tattile (o aptica) conserva per circa 2-3 secondi le sensazioni di pressione, temperatura e texture. Pensa a quando tocchi qualcosa al buio: quella capacità di “sentire ancora” la superficie per un momento dopo averla toccata è merito di questo sistema. È importante per esplorare gli oggetti e per la propriocezione, cioè la percezione del nostro corpo nello spazio.
La memoria olfattiva ha qualcosa di particolare. La fase sensoriale iniziale è breve come per gli altri sensi, ma gli odori sembrano avere una corsia preferenziale verso i ricordi a lungo termine. Ecco spiegato perché un profumo può farti tornare in mente un ricordo di anni fa con una vivezza incredibile.
Il gusto, infine, ha un suo registro sensoriale che però è strettamente legato all’olfatto – tanto che spesso è difficile separarli. È stato studiato meno degli altri proprio per questa sovrapposizione.
Memoria sensoriale a breve e lungo termine: come si collegano
Il rapporto tra memoria sensoriale e attenzione è cruciale per capire come passiamo dalla percezione al ricordo vero e proprio. In ogni momento i nostri sensi captano una quantità enorme di informazioni. Tutte vengono registrate per un attimo nella memoria sensoriale, ma solo una piccola parte va oltre.
L’attenzione selettiva funziona come un filtro. Decide cosa dalla memoria sensoriale passa alla memoria a breve termine (o memoria di lavoro) per essere elaborato più a fondo. Questa selezione può avvenire in due modi: automaticamente, quando qualcosa di saliente (un rumore forte, un movimento improvviso) cattura la nostra attenzione, oppure in modo volontario, quando decidiamo consapevolmente di prestare attenzione a qualcosa.
C’è un fenomeno che dimostra alla perfezione questi limiti: la “cecità al cambiamento”. In alcuni esperimenti, le persone non notano cambiamenti anche evidenti in una scena se non stanno guardando proprio lì, nonostante il cambiamento sia stato sicuramente registrato nella memoria iconica.
Lo stesso vale per i suoni: la “sordità non attenzionale” ci mostra che anche stimoli uditivi importanti possono sfuggirci se siamo concentrati su altro, pur essendo stati catturati dalla memoria ecoica.
Questo ci fa capire una cosa importante: la memoria sensoriale cattura molto più di quanto arrivi alla nostra consapevolezza. È solo la punta dell’iceberg di tutto quello che i nostri sensi stanno registrando.
Esempio di memoria sensoriale nella vita quotidiana
Per rendere concreto il concetto, pensa a quando guardi un film. Quello che percepisci come movimento fluido è in realtà una sequenza di immagini fisse. La memoria iconica tiene insieme queste immagini per quella frazione di secondo necessaria a creare l’illusione del movimento continuo.
Oppure pensa a quando ascolti musica: la memoria ecoica ti permette di percepire una melodia come un insieme coerente invece che come una serie sconnessa di note singole. Senza di essa, la musica perderebbe completamente il suo senso.
Un altro esempio classico: quando qualcuno ti parla e tu sei distratto, spesso chiedi “cosa?” ma poi, mentre la parola ti esce di bocca, ti accorgi di aver già capito. Questo succede perché la memoria ecoica ha conservato le ultime parole pronunciate, permettendoti di “riascoltarle” mentalmente e recuperare il senso.
Memoria sensoriale in psicologia: sviluppo e cambiamenti
La memoria sensoriale non è qualcosa di fisso che rimane uguale per tutta la vita. Si sviluppa e si modifica.
I neonati hanno già dei registri sensoriali funzionanti fin dai primi mesi. Questo permette loro di elaborare informazioni complesse anche se le loro capacità attentive e di memoria sono ancora limitate. Un bambino piccolo può riconoscere il volto della madre o reagire alla sua voce proprio grazie a questi sistemi.
Durante l’infanzia, quello che migliora non è tanto la capacità della memoria sensoriale in sé, quanto l’abilità di selezionare le informazioni rilevanti. I bambini piccoli si distraggono più facilmente perché sono meno bravi a filtrare gli stimoli irrilevanti catturati dalla memoria sensoriale.
Con l’invecchiamento normale, la buona notizia è che la memoria sensoriale rimane abbastanza preservata, anche quando altre forme di memoria iniziano a declinare. Tuttavia, la velocità con cui trasferiamo le informazioni dalla memoria sensoriale agli stadi successivi può rallentare, contribuendo ad alcune difficoltà percettive tipiche dell’età.
Nelle malattie neurodegenerative come l’Alzheimer, invece, possono manifestarsi alterazioni nella memoria sensoriale già nelle fasi iniziali. Questi cambiamenti possono contribuire ai problemi percettivi e attentivi che spesso precedono i deficit di memoria più evidenti.
 Psico.it Psicologia, Psicoterapia e Benessere
Psico.it Psicologia, Psicoterapia e Benessere