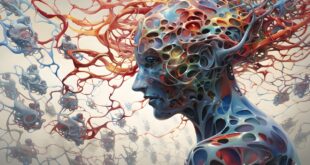Non è raro incontrare persone che ammettono, talvolta con un tono tra l’ironia e l’imbarazzo, di avere paura di stare soli. La paura di stare da soli però non è sempre una semplice ansia nel passare lunghi periodi in solitudine, ma può essere una vera e propria fobia che impedisce a chi ne soffre di riuscire a passare anche del tempo minimo in solitudine.
Ma la paura di rimanere soli, o peggio, la fobia di rimanere soli, ha poco a che vedere con la situazione oggettiva. Spesso non dipende dal numero di amici, dal fatto di avere o meno un partner, una famiglia o una rete sociale. Piuttosto, riguarda l’esperienza soggettiva della solitudine: la percezione che, in assenza dell’altro, qualcosa in noi si svuoti o perda senso.
Quando si parla di ansia da solitudine, si fa riferimento a una forma di disagio che può manifestarsi sotto forma di irrequietezza, malinconia, sensazione di inutilità o persino panico.
Non è raro che chi vive questa condizione cerchi costantemente la presenza di qualcuno, non per desiderio autentico di relazione, ma come tentativo di placare un vuoto interiore.
Le radici affettive della paura di stare da soli
La paura della solitudine nella maggior parte dei casi scaturisce da esperienze traumatiche nel periodo infantile. Nel corso dei primi anni di vita, infatti, è necessario sviluppare un senso di sicurezza e di tolleranza all’assenza, e questo avviene in modo naturale.
Quando un bambino cresce con figure di riferimento emotivamente disponibili, presenti e prevedibili, impara a fidarsi del fatto che, anche se temporaneamente separato, non sarà abbandonato.
Interiorizza la presenza dell’altro, che diventa una base sicura dentro di sé. Al contrario, in caso di esperienze precoci di trascuratezza, abbandono, o relazioni instabili, queste possono generare un senso profondo di insicurezza e di vuoto, che si ripresenta nella vita adulta ogni volta che si è costretti a confrontarsi con l’assenza.
La paura di restare soli può nascere anche da esperienze più tarde: una separazione, un lutto, un trasferimento improvviso, la perdita del lavoro o l’uscita da una relazione lunga. Eventi che mettono in discussione la continuità dell’identità personale, spesso intrecciata con la presenza dell’altro. In questi casi, il tempo della solitudine si carica di significati legati al fallimento, al rifiuto, alla non appartenenza.
Quando la paura di vivere da soli rende difficile vivere
Per alcune persone, l’idea di vivere senza una presenza accanto – che sia un partner, un familiare, un amico – genera una tale angoscia da condizionare le scelte più importanti della vita.
Si resta in relazioni che non nutrono, si evitano cambiamenti che comporterebbero un periodo di isolamento, si rinuncia a viaggi, esperienze, talvolta perfino a opportunità professionali, pur di non affrontare la prospettiva di vivere da soli.
In questi casi, la paura di stare da soli non è più una semplice inquietudine: diventa una dinamica disfunzionale, che limita la libertà e rafforza il ciclo della dipendenza emotiva.
La persona, piuttosto che imparare a regolare da sé le proprie emozioni, delega all’altro il compito di colmare quel senso di mancanza, alimentando così una costante tensione relazionale e un’illusione di controllo.
Solitudine e identità: chi sono senza lo sguardo dell’altro?
Un aspetto spesso sottovalutato, ma di grande rilievo, riguarda la costruzione dell’identità. In una società iperconnessa, dove il valore personale è frequentemente misurato attraverso la visibilità, i like, le conferme esterne, l’assenza dell’altro viene interpretata come una sorta di sparizione esistenziale. Non essere visti, non essere ascoltati, non essere connessi può tradursi in un senso di inesistenza.
Chi vive un’identità poco consolidata, fragile o molto dipendente dall’approvazione esterna, tende a temere la solitudine perché la vive come una minaccia alla propria continuità psichica. In assenza di un interlocutore, di uno specchio, di un “tu” che confermi il “sé”, si fatica a sentire di esistere.
Questa dinamica, in psicologia, viene studiata in relazione alla struttura narcisistica della personalità, ma si presenta in forma sfumata in molte persone che hanno difficoltà a stare da sole senza provare disagio.
Superare la paura della solitudine: un processo, non un’istruzione
Affrontare la paura di rimanere soli non significa imparare a “non averne più”, ma piuttosto trasformare il modo in cui si convive con quella sensazione. Il primo passo è riconoscerla, darle un nome, accettare che esiste e che può parlare di qualcosa di più profondo rispetto alla semplice mancanza di compagnia.
Successivamente, è importante esplorare il rapporto con il silenzio, con i tempi morti, con gli spazi vuoti, provare a starci, senza riempirli subito. Osservare cosa accade, cosa emerge, quali pensieri affiorano, quali emozioni si manifestano. In molti casi, accompagnati da un lavoro terapeutico, si scopre che quel vuoto tanto temuto non è il nemico, ma un contenitore che può essere riempito in modi nuovi.
Esistono strumenti psicologici e pratiche utili per questo percorso, come ad esempio la mindfulness, che può aiutare a riconnettersi con il momento presente senza giudizio.
La scrittura riflessiva permette di dare forma ai propri pensieri, rendendoli meno opprimenti. Anche la riorganizzazione dello spazio domestico può avere un effetto terapeutico: vivere da soli non significa essere abbandonati, ma abitare uno spazio che riflette la propria identità e i propri desideri.
Riconoscere il valore della solitudine autentica
È necessario distinguere tra la solitudine imposta – quella che fa soffrire, che isola, che spegne – e la solitudine scelta, quella che rigenera, che permette di ascoltarsi davvero, che apre nuove prospettive interiori.
La seconda non è né facile né sempre piacevole, ma può diventare una risorsa straordinaria per sviluppare autonomia, creatività, consapevolezza di sé. Riscoprire il proprio tempo, i propri ritmi, i propri bisogni. Smettere di vivere in funzione dell’altro e cominciare a vivere anche – e non solo – per sé. È qui che la paura di restare soli inizia a svanire, non perché sparisce del tutto, ma perché perde il suo potere paralizzante.
Quando bisogna chiedere aiuto?
In alcuni casi, la fobia di rimanere soli può assumere una forma clinica, radicata in disturbi d’ansia, attacchi di panico, dipendenza affettiva, o sintomi depressivi. In questi casi, è importante non ridurre il problema a una questione di forza di volontà.
Chiedere aiuto a un professionista della salute mentale, come uno psicologo o uno psichiatra non è una sconfitta, ma il primo passo per uscire da una prigione invisibile che spesso si autoalimenta.
La solitudine, se affrontata con gli strumenti giusti e con il supporto adeguato, può diventare uno spazio fertile dove riscoprirsi. Non è un nemico da sconfiggere, ma una condizione da attraversare con rispetto, curiosità e un pizzico di coraggio. Perché solo quando si impara davvero a stare con sé stessi, senza paura, si diventa capaci di scegliere – e non solo desiderare – la compagnia degli altri.
 Psico.it Psicologia, Psicoterapia e Benessere
Psico.it Psicologia, Psicoterapia e Benessere