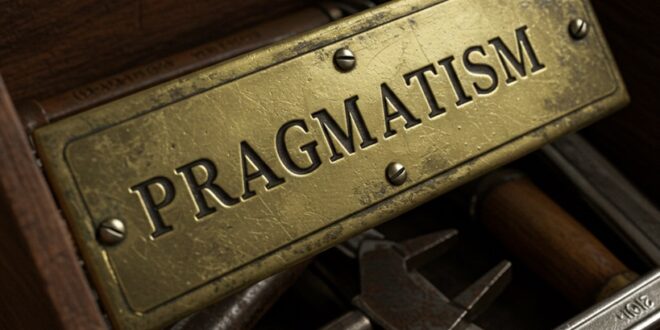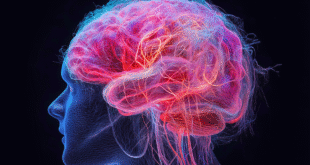Il significato di pragmatico rappresenta una dimensione fondamentale nello studio del linguaggio. Mentre la semantica si occupa del significato convenzionale dei termini e delle frasi, la pragmatica esplora come il contesto, le intenzioni dei parlanti e le conoscenze condivise influenzino l’interpretazione di ciò che viene detto.
Il significato pragmatico emerge dunque proprio nell’intersezione tra le parole pronunciate e il contesto in cui vengono utilizzate, rivelando la complessità della comunicazione umana che trascende il semplice codice linguistico.
Quando comunichiamo, raramente ci limitiamo a trasmettere informazioni in modo diretto e letterale. Piuttosto, affidiamo parte del messaggio a elementi impliciti che l’interlocutore deve inferire. Ebbene, questa capacità di comunicare e comprendere significati che non sono esplicitamente dichiarati costituisce il cuore del significato pragmatico, un aspetto che distingue la comunicazione umana da semplici sistemi di codifica e decodifica dell’informazione.
Fondamenti teorici della pragmatica
La pragmatica come disciplina formale iniziò a svilupparsi nella seconda metà del XX secolo, sebbene riflessioni su come il contesto influenzi il significato fossero presenti già nel pensiero filosofico precedente.
Un contributo fondamentale venne dal filosofo del linguaggio H. Paul Grice, che introdusse il principio di cooperazione e le massime conversazionali. Secondo Grice, la comunicazione efficace si basa su un accordo implicito tra i parlanti di cooperare nel dialogo, seguendo massime di quantità, qualità, relazione e modalità. Quando queste massime vengono apparentemente violate, gli ascoltatori tendono a cercare implicature conversazionali, ovvero significati aggiuntivi che il parlante intende comunicare indirettamente.
Un altro contributo teorico essenziale venne da John L. Austin e successivamente da John Searle con la teoria degli atti linguistici. Questa teoria riconosce che parlare non significa semplicemente pronunciare frasi, ma compiere azioni attraverso le parole, come promettere, ordinare, chiedere o dichiarare. Il significato pragmatico emerge proprio dalla forza illocutoria dell’enunciato, ovvero dall’azione che il parlante intende compiere pronunciandolo, e dagli effetti perlocutori, cioè le conseguenze che l’enunciato produce sull’interlocutore e sulla situazione comunicativa.
Leggi anche Machiavellismo: significato e implicazioni psicologiche
Contesto e significato della pragmatica
Il contesto gioca un ruolo determinante nell’emergere del significato pragmatico. Quando diciamo “contesto”, ci riferiamo a molteplici dimensioni: il contesto fisico immediato, il contesto socioculturale più ampio, il contesto linguistico precedente (cotesto), le conoscenze condivise tra i parlanti e la relazione interpersonale tra gli interlocutori.
Per esempio, la semplice frase “Fa freddo qui” può assumere significati pragmatici diversi a seconda del contesto: può essere una semplice osservazione sulle condizioni ambientali, una richiesta indiretta di chiudere una finestra, un suggerimento per alzare il riscaldamento o persino un commento sull’atmosfera emotiva di un ambiente. L’interlocutore interpreta il significato pragmatico basandosi non solo sulle parole pronunciate, ma anche su indizi contestuali come l’intonazione, il linguaggio non verbale, le conoscenze condivise sulla situazione e le convenzioni sociali.
Implicature e presupposizioni
Le implicature rappresentano uno degli aspetti più affascinanti del significato pragmatico. Si tratta di inferenze che l’ascoltatore compie a partire dall’enunciato, ma che non sono parte del suo significato letterale. Grice distingueva tra implicature convenzionali, legate alle convenzioni linguistiche, e implicature conversazionali, che emergono nel contesto specifico dello scambio comunicativo.
Ad esempio, se alla domanda “Vuoi andare al cinema stasera?” qualcuno risponde “Devo studiare per l’esame“, pragmaticamente comprendiamo che la risposta è negativa, anche se letteralmente la persona ha solo affermato di avere un impegno di studio. Questa inferenza si basa sulla massima di relazione: assumiamo che la risposta sia pertinente alla domanda e quindi ne deduciamo il significato implicito.
Le presupposizioni, invece, sono informazioni date per scontate nell’enunciato. Quando diciamo “Mario ha smesso di fumare“, presupponiamo che Mario fumasse in precedenza. Queste presupposizioni fanno parte del background informativo su cui si innesta il significato pragmatico dell’enunciato principale.
Deissi e riferimento
Un altro aspetto cruciale del significato pragmatico riguarda i fenomeni di deissi e riferimento. La deissi concerne espressioni come “io”, “qui”, “ora”, “questo”, il cui significato dipende interamente dal contesto di enunciazione. Per interpretare correttamente “Ci vediamo qui domani”, l’interlocutore deve identificare il luogo e il momento di riferimento a partire dal contesto.
Similmente, il riferimento a persone, oggetti ed eventi attraverso espressioni nominali richiede spesso una negoziazione pragmatica tra i parlanti. Quando diciamo “Quel professore” o “La situazione di ieri”, l’identificazione corretta del referente dipende da conoscenze condivise e dalla salienza di certi elementi nel contesto comunicativo.
Significato pagmatico nella comunicazione interculturale
Il significato pragmatico assume particolare rilevanza nella comunicazione interculturale, dove differenze nelle convenzioni pragmatiche possono generare fraintendimenti anche quando la competenza grammaticale e lessicale è adeguata. Ogni cultura sviluppa proprie norme pragmatiche riguardo alla cortesia, all’espressione di richieste, critiche o complimenti, alla gestione dei turni conversazionali e molto altro.
Ad esempio, in alcune culture una richiesta indiretta come “Ti dispiacerebbe aprire la finestra?” viene percepita come appropriatamente cortese, mentre in altre potrebbe risultare inutilmente ambigua o persino scortese per la sua indirectness. Comprendere le dimensioni pragmatiche della comunicazione diventa quindi essenziale per un’interazione efficace in contesti multiculturali.
Applicazioni pratiche della pragmatica
La consapevolezza del significato pragmatico trova numerose applicazioni pratiche in ambiti diversi. Nell’insegnamento delle lingue, un approccio che integri la competenza pragmatica permette agli studenti di comunicare in modo culturalmente appropriato, evitando il rischio di apparire involontariamente scortesi o bizzarri pur parlando grammaticalmente in modo corretto.
Nel campo dell’intelligenza artificiale e della linguistica computazionale, la sfida di programmare sistemi in grado di comprendere e generare significati pragmatici rappresenta uno dei fronti più avanzati della ricerca. Le difficoltà che i sistemi di traduzione automatica incontrano con ironia, sarcasmo e implicature mostrano quanto la dimensione pragmatica sia ancora difficile da modellare computazionalmente.
Nella comunicazione istituzionale e nel marketing, la comprensione dei meccanismi pragmatici consente di costruire messaggi più efficaci, capaci di suscitare le giuste inferenze nel pubblico target e di evitare interpretazioni indesiderate.
 Psico.it Psicologia, Psicoterapia e Benessere
Psico.it Psicologia, Psicoterapia e Benessere