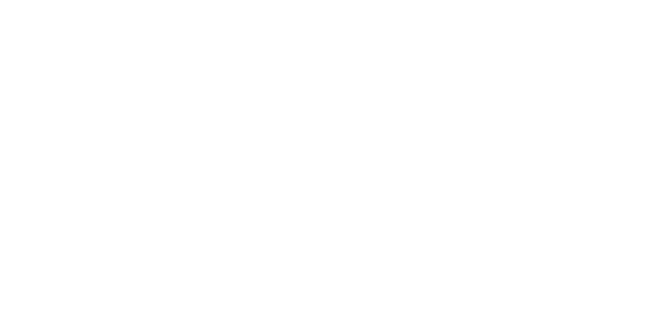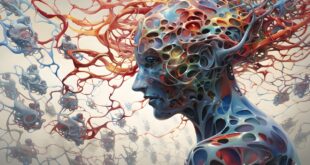Il termine ecoansia è entrato da qualche anno nel linguaggio comune, ma resta difficile darne una definizione unica e condivisa.
Si tratta di una forma di disagio psicologico che nasce dalla percezione delle minacce ambientali e climatiche: eventi estremi, notizie allarmanti, immagini di incendi e inondazioni, rapporti scientifici che mostrano scenari sempre più preoccupanti.
Non parliamo di una patologia riconosciuta dai manuali diagnostici, bensì di un insieme di vissuti che spaziano dall’ansia vera e propria alla tristezza, dal senso di impotenza al timore per il futuro proprio e delle generazioni a venire.
Molti studiosi sottolineano come non sia corretto trattare l’ecoansia come una malattia, perché non sempre si traduce in una condizione clinica. È piuttosto una reazione emotiva che accompagna la consapevolezza crescente delle trasformazioni in atto, e che può diventare invalidante solo in alcuni casi.
Si tratta di una sfumatura importante: etichettare con troppa leggerezza rischia di medicalizzare un fenomeno che, almeno in parte, rappresenta una risposta naturale a una minaccia reale.
Le varie espressioni dell’ecoansia
Le espressioni usate per descrivere questi stati d’animo sono numerose: solastalgia, ecoansia, paura del clima, dolore ecologico. La varietà terminologica riflette il tentativo di catturare esperienze che non si lasciano imbrigliare facilmente.
Già la definizione di “ansia”, in ambito clinico, è complessa e dibattuta: ancor più lo diventa quando la si lega a un concetto vago come “cambiamento climatico”.
Gli psicologi stanno lavorando alla costruzione di scale e indici che permettano di misurare questo fenomeno. Alcuni strumenti hanno un taglio clinico, altri si limitano a indagini sociologiche e culturali.
Il punto aperto riguarda la reale utilità di tali misurazioni: fino a che punto il bisogno di quantificare non rischia di distorcere l’esperienza soggettiva delle persone, inducendo ulteriore stress invece di comprenderlo?
Leggi anche: Come percepiamo l’ambiente circostante? Test della Emory University
Ecoansia? Non è una patologia moderna
Anche se il lessico è recente, l’ecoansia non è certo un’invenzione moderna. La storia offre numerosi esempi di comunità travolte da mutamenti ambientali.
L’impero Khmer, i Maya o i popoli Pueblo hanno conosciuto periodi di declino legati a siccità, deforestazione o alterazioni delle risorse idriche.
Non possiamo sapere con esattezza come abbiano vissuto psicologicamente questi cambiamenti, ma è ragionevole ipotizzare che spaesamento e angoscia abbiano avuto un ruolo nelle loro decisioni, dalle migrazioni collettive fino al collasso sociale.
La differenza con oggi sta nell’immediatezza e nella scala globale. I cambiamenti climatici contemporanei sono costantemente sotto i nostri occhi: i media diffondono immagini e dati, i rapporti scientifici vengono commentati in tempo reale, i social amplificano ogni allarme.
L’esperienza individuale non si limita più al proprio contesto, ma si estende a un orizzonte planetario.
La dimensione personale dell’ecoansia
Chi sperimenta ecoansia può descrivere sintomi diversi: pensieri intrusivi legati al futuro, difficoltà a dormire, preoccupazione costante per eventi climatici, sensazione di impotenza di fronte alla vastità del problema.
Per alcune persone, soprattutto giovani, questo sentimento diventa una sorta di ombra che accompagna le scelte di vita: dalla decisione di non avere figli al timore di non poter programmare una carriera stabile in un mondo percepito come fragile.
In molti casi, tuttavia, l’ecoansia non degenera in un disturbo. Può persino tradursi in energia motivazionale, spingendo a impegnarsi in azioni quotidiane o collettive.
La distinzione tra reazione sana e disagio patologico passa dalla capacità di elaborare il timore e trasformarlo in comportamento attivo, anziché restarne paralizzati.
Leggi anche: Come accrescere le potenzialità dei bambini verso l’ambiente
Il ruolo della ricerca scientifica
Le università e i centri di studio stanno cercando di tracciare una mappa del fenomeno. Non è semplice: ogni cultura ha un diverso modo di concepire la salute mentale e di esprimere le emozioni.
Una scala di valutazione elaborata in Europa può non avere lo stesso significato in Asia o in Africa. Inoltre, c’è il rischio che la ricerca, concentrandosi solo sul lato negativo, finisca per rafforzare la percezione di disperazione.
Alcuni studiosi suggeriscono di affiancare ai questionari sull’ansia climatica anche indagini sulla speranza climatica: la fiducia nella possibilità di cambiamento, la soddisfazione per azioni virtuose, la capacità di immaginare soluzioni.
Senza questa dimensione, ogni analisi rischia di restituire un quadro parziale e deprimente, che potrebbe aggravare lo stesso disagio che intende studiare.
Quando la consapevolezza diventa pesante
L’ecoansia colpisce soprattutto le persone più informate e sensibili al tema. Non è un caso che molti giovani attivisti per il clima abbiano raccontato pubblicamente le proprie difficoltà emotive. La conoscenza approfondita dei dati scientifici e la percezione di una responsabilità collettiva non distribuita equamente generano un senso di ingiustizia difficile da sopportare.
In questo contesto, la differenza la fanno le reti di sostegno: famiglie, comunità locali, associazioni.
Avere qualcuno con cui condividere timori e progetti riduce l’isolamento e restituisce un margine di controllo. Anche le istituzioni hanno un ruolo: politiche ambientali concrete, comunicate con trasparenza, non solo agiscono sul piano reale, ma contribuiscono a ridurre l’angoscia diffusa.
La sfida culturale
Parlare di ecoansia significa anche affrontare un tabù: quello delle emozioni legate alla crisi ecologica. Non basta discutere di emissioni, tecnologie o transizioni energetiche, se non si riconosce che la crisi climatica produce ferite psicologiche. Dare spazio a questi temi non equivale a deresponsabilizzare, ma a considerare l’essere umano nella sua interezza.
Il futuro della ricerca andrà probabilmente in questa direzione: comprendere come il linguaggio, le pratiche sociali e le politiche pubbliche possano trasformare l’ecoansia da fardello paralizzante a stimolo per l’azione. Un compito delicato, che richiede equilibrio tra il riconoscimento della sofferenza e la valorizzazione della resilienza.
 Psico.it Psicologia, Psicoterapia e Benessere
Psico.it Psicologia, Psicoterapia e Benessere