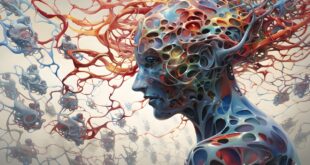Nel complesso ecosistema della società contemporanea, i disagi sociali rappresentano manifestazioni multidimensionali di squilibri strutturali, relazionali e psicologici che permeano il tessuto collettivo. Questi fenomeni, lungi dall’essere semplici anomalie isolate, costituiscono segnali significativi delle tensioni, contraddizioni e fragilità che caratterizzano il vivere sociale nel ventunesimo secolo.
Comprendere i disagi sociali richiede uno sguardo multidisciplinare che integri prospettive psicologiche, sociologiche, economiche e antropologiche, riconoscendo la natura interconnessa dei fenomeni che influenzano il benessere collettivo e individuale.
La natura multidimensionale del disagio sociale
Il disagio sociale può essere concettualizzato come uno stato di malessere che emerge dall’interazione problematica tra l’individuo e il suo ambiente sociale. Questo malessere si manifesta attraverso una molteplicità di forme, che vanno dall’esclusione economica all’isolamento relazionale, dalla marginalizzazione culturale alla mancanza di riconoscimento identitario, dalla precarietà esistenziale all’impossibilità di accedere a risorse materiali e simboliche essenziali per una vita dignitosa.
A differenza del disagio puramente psicologico, che può essere circoscritto alla dimensione intrapsichica, il disagio sociale implica necessariamente una componente relazionale e sistemica. Esso non riguarda semplicemente il modo in cui l’individuo percepisce e interpreta la propria condizione, ma coinvolge anche le strutture sociali, le dinamiche di potere, le disparità distributive e i meccanismi di inclusione ed esclusione che caratterizzano un determinato contesto collettivo.
La psicologia sociale ci insegna che questi disagi non possono essere pienamente compresi o affrontati se considerati esclusivamente come problemi individuali. Robert K. Merton, con la sua teoria dell’anomia, evidenziava già negli anni ’30 come molti comportamenti devianti o problematici fossero in realtà risposte adattive a contraddizioni strutturali della società, come il divario tra obiettivi culturalmente definiti e mezzi legittimi per raggiungerli. Analogamente, la prospettiva ecologica di Urie Bronfenbrenner sottolinea come il benessere psicosociale emerga dall’interazione tra l’individuo e i diversi sistemi ambientali che lo circondano, dai microsistemi delle relazioni immediate ai macrosistemi culturali e istituzionali.
Leggi anche: Come approcciarsi all’ansia sociale e contrastarla
Radici storiche e trasformazioni contemporanee
I disagi sociali contemporanei affondano le loro radici in processi storici di lungo periodo, ma assumono caratteristiche specifiche nell’attuale fase di sviluppo socioeconomico. La transizione dalle società tradizionali a quelle industriali e post-industriali ha comportato profondi cambiamenti nei sistemi di produzione, nelle strutture familiari, nei sistemi valoriali e nelle modalità di costruzione identitaria, generando nuove forme di vulnerabilità e disagio.
La rivoluzione industriale, con il passaggio da comunità rurali relativamente stabili a contesti urbani caratterizzati da anonimato e mobilità, ha dato origine a quelli che il sociologo Émile Durkheim definiva stati di “anomia”, ovvero situazioni di disorientamento e perdita di riferimenti normativi chiari. La modernità ha portato con sé la promessa di maggiore libertà individuale e opportunità di autorealizzazione, ma ha anche eroso le tradizionali reti di supporto sociale e comunitario che fornivano contenimento e significato esistenziale.
Nella società contemporanea, caratterizzata da processi di globalizzazione, digitalizzazione e crescente individualizzazione, questi fenomeni si sono ulteriormente intensificati. La sociologa Eva Illouz parla di “capitalismo emotivo” per descrivere come l’economia di mercato abbia colonizzato anche la sfera delle emozioni e delle relazioni intime, trasformandole in beni di consumo e generando nuove forme di disuguaglianza emotiva. L’accelerazione sociale teorizzata da Hartmut Rosa si traduce in una crescente pressione temporale che genera stati cronici di affanno e inadeguatezza, mentre la precarizzazione del lavoro descritta da Guy Standing con il concetto di “precariato” produce insicurezza esistenziale e difficoltà di progettazione biografica a lungo termine.
Leggi anche: Soffri di ansia sociale? Ecco come gestirla e assumersi alcuni rischi accettabili
Manifestazioni contemporanee del disagio sociale
Nella società attuale, il disagio sociale si manifesta attraverso molteplici fenomeni che interessano diverse fasce della popolazione e ambiti dell’esperienza collettiva.
La solitudine rappresenta una delle espressioni più pervasive del disagio contemporaneo, con evidenze empiriche che ne documentano la crescente diffusione in tutte le fasce d’età. Paradossalmente, nell’era dell’iperconnessione digitale, sempre più persone sperimentano un profondo senso di isolamento relazionale e mancanza di appartenenza significativa. La psicologa Sherry Turkle ha coniato l’espressione “insieme ma soli” per descrivere questa contraddizione della socialità contemporanea, in cui la moltiplicazione delle connessioni virtuali si accompagna spesso a un impoverimento della qualità delle relazioni reali.
Le disuguaglianze socioeconomiche costituiscono un’altra dimensione fondamentale del disagio sociale. In molti paesi, tra cui l’Italia, si osserva un progressivo ampliamento del divario tra ricchi e poveri, con la formazione di sacche di povertà persistente anche in contesti di generale prosperità economica. Questo fenomeno non comporta solo privazione materiale, ma anche esclusione da opportunità educative, culturali e partecipative, con conseguenze significative sul benessere psicologico e sulla coesione sociale. Come evidenziato dagli studi di Richard Wilkinson e Kate Pickett, le società più diseguali tendono a presentare maggiori problemi sociali e sanitari a tutti i livelli della stratificazione sociale.
La crisi del lavoro rappresenta un’ulteriore manifestazione del disagio sociale contemporaneo. Non si tratta solo di disoccupazione strutturale, ma anche di precarizzazione, sottooccupazione, lavoro povero e perdita di senso nell’attività lavorativa. Il sociologo Richard Sennett ha descritto come la flessibilizzazione del mercato del lavoro, oltre a generare insicurezza economica, produca anche una “corrosione del carattere”, minando la possibilità di costruire narrazioni coerenti della propria identità professionale e personale. La difficoltà di conciliare vita lavorativa e familiare costituisce un ulteriore elemento di stress e conflitto, che grava in modo particolare sulle donne e sulle famiglie con figli piccoli o persone non autosufficienti.
La crisi ambientale e climatica rappresenta una dimensione emergente del disagio sociale, che si manifesta attraverso quello che viene definito “eco-ansia” o “solastalgia” (sofferenza causata dal deterioramento dell’ambiente di vita). La consapevolezza delle minacce esistenziali poste dal cambiamento climatico e dal degrado ecosistemico genera stati di angoscia esistenziale e preoccupazione per il futuro, particolarmente intensi tra le generazioni più giovani, che si trovano a fronteggiare l’eredità problematica delle scelte economiche e politiche delle generazioni precedenti.
Gruppi vulnerabili e intersezionalità
Il disagio sociale non colpisce in modo uniforme tutti i membri della società, ma tende a concentrarsi in gruppi che presentano specifiche vulnerabilità socioeconomiche, culturali o identitarie. Tuttavia, è importante evitare una visione eccessivamente categoriale, riconoscendo come le diverse dimensioni di svantaggio spesso si intersechino e si potenzino reciprocamente, secondo la prospettiva dell’intersezionalità teorizzata da Kimberlé Crenshaw.
I giovani rappresentano attualmente una categoria particolarmente esposta a forme specifiche di disagio sociale. La difficoltà di inserimento nel mercato del lavoro, la precarietà abitativa, l’indebitamento per motivi di studio, la dipendenza economica prolungata dalla famiglia d’origine costituiscono fattori che ostacolano i percorsi di autonomizzazione e progettualità. Non sorprende che in molti paesi europei, inclusa l’Italia, si osservi un significativo aumento dei disturbi psicologici tra adolescenti e giovani adulti, dalla depressione ai disturbi d’ansia, dai comportamenti autolesivi alle dipendenze tecnologiche.
Gli anziani, soprattutto quelli soli o con risorse economiche limitate, rappresentano un altro gruppo particolarmente vulnerabile. L’invecchiamento della popolazione, combinato con il progressivo indebolimento dei sistemi di welfare e la trasformazione delle strutture familiari tradizionali, produce nuove forme di emarginazione e abbandono sociale. La solitudine degli anziani non è solo un problema affettivo, ma comporta anche difficoltà pratiche di accesso ai servizi, assistenza sanitaria inadeguata e impossibilità di partecipare pienamente alla vita sociale.
Le persone con background migratorio sperimentano forme specifiche di disagio legate ai processi di integrazione e alle dinamiche di discriminazione e razzismo. Il concetto di “doppia assenza” elaborato dal sociologo Abdelmalek Sayad descrive efficacemente la condizione esistenziale di chi non è più pienamente parte della società d’origine ma non è ancora pienamente accettato nella società d’arrivo. Questo limbo identitario e giuridico può generare profonde forme di sofferenza psicosociale, accentuate dalle difficoltà linguistiche, economiche e burocratiche che caratterizzano l’esperienza migratoria.
Implicazioni per la salute mentale e il benessere psicologico
I disagi sociali presentano strette interconnessioni con la salute mentale individuale, influenzandola e venendone a loro volta influenzati. La psichiatria critica, da Franco Basaglia a David Smail, ha sottolineato come molti disturbi psicologici non possano essere compresi e affrontati adeguatamente senza considerare le condizioni sociali, economiche e politiche in cui emergono.
La depressione, in particolare, può essere letta non solo come manifestazione di squilibri neurochimici o vulnerabilità psicologiche individuali, ma anche come espressione di condizioni sociali alienanti e oppressive. Il filosofo Byung-Chul Han parla di “società della stanchezza” per descrivere come l’imperativo neoliberista dell’autorealizzazione e della performance produca stati cronici di esaurimento psicoemotivo. Mark Fisher ha coniato il termine “realismo capitalista” per descrivere come l’attuale sistema socioeconomico naturalizza la depressione, presentandola come problema individuale da gestire farmacologicamente piuttosto che come sintomo di un malessere collettivo che richiederebbe trasformazioni strutturali.
L’ansia sociale, i disturbi alimentari, le dipendenze comportamentali possono similmente essere interpretati come tentativi disfunzionali di adattamento a pressioni sociali contraddittorie o insostenibili. Come osserva lo psicologo clinico David Smail, molte forme di psicopatologia rappresentano “distress signals” che segnalano la presenza di problemi sociali più ampi, e la loro medicalizzazione rischia di oscurare le radici socioeconomiche e politiche del disagio.
Interventi e strategie di prevenzione
Affrontare efficacemente i disagi sociali richiede approcci integrati che operino simultaneamente su molteplici livelli, dalla trasformazione delle strutture socioeconomiche alla promozione di risorse psicosociali protettive, dall’elaborazione di politiche pubbliche inclusive alla creazione di spazi comunitari di supporto e partecipazione.
A livello di politiche pubbliche, emerge la necessità di ripensare i sistemi di welfare in direzione universalistica, orientandoli non solo all’assistenza delle situazioni di emergenza, ma alla promozione attiva dell’inclusione e della partecipazione. Misure come il reddito di base, politiche abitative inclusive, servizi educativi e sanitari accessibili rappresentano strumenti fondamentali per prevenire e mitigare i disagi sociali, riducendo le disuguaglianze strutturali che ne costituiscono il terreno fertile.
A livello comunitario, la costruzione di reti solidali e spazi di aggregazione significativa rappresenta un antidoto potente all’atomizzazione sociale e alla solitudine. Esperienze come i gruppi di auto-mutuo aiuto, le iniziative di economia solidale, i progetti di rigenerazione urbana partecipata mostrano come sia possibile ricreare tessuti relazionali supportivi anche in contesti segnati da frammentazione e isolamento. La psicologia di comunità offre strumenti concettuali e metodologici preziosi per promuovere l’empowerment collettivo e la costruzione di comunità competenti, capaci di rispondere attivamente ai bisogni dei propri membri.
A livello individuale, l’approccio clinico ai disagi di origine sociale richiede una sensibilità particolare alle dimensioni contestuali e una capacità di connettere le esperienze soggettive alle condizioni strutturali che le influenzano. Modelli come la “terapia della testimonianza” sviluppata in contesti di violenza politica, l’approccio narrativo di Michael White, la terapia contestuale di Ivan Boszormenyi-Nagy offrono prospettive interessanti per una pratica clinica socialmente consapevole, che non riduca il disagio a problema intrapsichico ma riconosca e valorizzi le dimensioni relazionali, culturali e politiche dell’esperienza umana.
 Psico.it Psicologia, Psicoterapia e Benessere
Psico.it Psicologia, Psicoterapia e Benessere